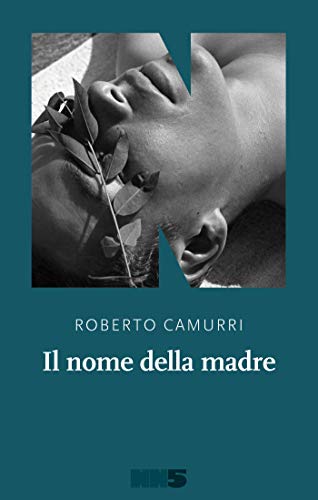Si può sopravvivere all’abbandono? A cosa condanna quel taglio netto e definitivo? In quale palude di forze, rancori, sentimenti, desideri, rimpianti costringe chi rimane? Quale forma può prendere l’assenza, la più tremenda, impensabile, marchiante forma di assenza, quella in cui è una madre ad abbandonare il proprio figlio? Ettore (il padre), Pietro (il figlio), Miriam (la donna che sarà la compagna del figlio) si muovono costantemente sull’orlo di questa assenza.
Il vuoto scavato dall’abbandono è un cratere lungo i cui bordi scivolosi i protagonisti de Il nome della madre (NN, 2020) di Roberto Camurri rischiano perennemente di precipitare. Una sorta di densità li avvolge, rende grevi, impacciati, i loro movimenti, vischioso il loro sentire, rarefatte le loro azioni che la scrittura di Camurri registra scomponendole, frazionandole in ogni elemento.
L’ “assenza presente” della madre è uno specchio nel quale ognuno dei protagonisti del romanzo di Camurri non scorge se stesso, ma l’altro, non definisce la propria identità ma misura la distanza (o la vicinanza) con la madre, scruta la somiglianza o difformità dall’unica azione che definisce il suo posto: l’abbandono. La madre è il sospetto, un pericolo, il segno di un contagio nascosto, un marchio che si agita nelle profondità e che spinge per affiorare, per frantumare la superficie rassicurante delle cose ma è anche lo stigma di un coraggio selvaggio, smisurato: il coraggio di recidere tutto.
“Sei come tua madre”, dice a Pietro il padre
“Tua madre ha fatto bene ad abbandonarti”, dice Miriam a Pietro
“Sarebbe stato meglio mi avessi abbandonato tu”, dice Pietro al padre.
Ma la madre è anche un nulla che si allarga, un vuoto che cresce, una figura sempre più trasparente. Pietro lotta per strappare a quella iridescenza una densità, a quella inconsistenza una forma che non abbui.
“Vorrebbe chiedergli troppe cose, chiedere troppe cose ai suoi nonni, agli amici di suo padre, a chiunque l’abbia conosciuta, vorrebbe degli indizi, minuscoli, soltanto per avere la certezza che quella donna, sua madre, sia davvero esistita, sia stata, un tempo, una persona reale e non soltanto un fantasma che, ora, davanti alle rovine della propria immaginazione, si aspetta di veder comparire in quella foschia”.
Quello che manca a Pietro, che viene sottratto al figlio, è il racconto, la storia di sua madre e, al tempo stesso, la possibilità di “intrecciare” la sua storia, la trama di parole che cuce gli avvenimenti di una vita, restituendo ad essi un senso. Il senso della vita. È il silenzio il nemico di Pietro. È questo il tradimento che gli adulti consumano alle sue spalle. La madre andandosene. Il padre, i nonni, sprofondando nella reticenza.
È nel mondo animale, nella sofferenza del mondo animale, che si compie una sorta di doppia epifania nella quale Pietro può afferrare il suo dolore, riunire assieme i lacerti del suo dolore e i lacerti della sua responsabilità. Nel dolore animale di una cagna a cui viene sottratto il suo cucciolo, il figlio riesce mettere a fuoco il nodo della sua disperazione.
Un urlo lancinante nella notte, padre e figlio che escono nel buio del cortile, guardinghi. Pochi passi e il mistero si risolve: si tratta di un gatto a cui il cane Briciola ha spezzato la schiena. Dinanzi alla sofferenza insensata dell’animale, Pietro intravede una figura, luminescente, evanescente, eterea. Appare, scompare.
In quel momento, stretto tra il dolore dell’animale e lo strazio che quella figura gli provoca, Pietro “spera che tutto esploda, che la terra si squarci, che li ingoi, che ingoi quel gatto, che ingoi casa loro, che ingoi loro due in mezzo a quella pioggia, a quei tuoni che non emettono, che ingoi Fabbrico, sua madre ovunque si trovi”. Il padre punta la torcia contro il gatto ferito. Dice al figlio: lo uccidi tu?