La strada, la libertà, l’alcool, le donne, la disperazione, l’esaltazione, l’amicizia: come sottrarsi al fascino di Kerouac? Kerouac era il mito della strada: per me ragazzino rappresentava il sogno sconfinato della libertà, la rottura del piccolo mondo che mi stringeva e lo spalancamento di una cosa gigantesca, affascinante, tremenda che rispondeva al nome di America. Appartengo a una generazione che è stata inseguita, sedotta, folgorata dal mito americano. L’America per noi era ovunque. Era nei film western, nei telefilm tipo Saranno Famosi, in Rocky Balboa che correva per strada attorniato da un nugolo di bambini. Per me l’America è stata soprattutto Bruce Springsteen che, un giorno ormai lontanissimo, è entrato dentro la mia vita con la bandana, la chitarra al collo, urlando come un pazzo. Non avevo mai visto nulla di così devastante prima di allora. E Springsteen cantava di automobili di amori di strade, insomma romanticismo allo stato puro, o almeno era quello che io riuscivo ad afferrare a 15 anni. Passare a Kerouac è stato naturale. Da ragazzino ho così – come credo quasi tutti i miei coetanei – letto Sulla strada. Credo che ci sia una copia di Sulla strada in quasi tutte le case. Poi ho abbandonato Kerouac per ritrovarlo da adulto. Forse, chissà, mi aspettava.

Alcuni anni fa Antonio Spadaro ha riletto Kerouac, riscoprendolo, riscoprendo qualcosa che era stato dimenticato o ignorato. Sulla strada è stata la fortuna di Jack ma anche la sua condanna. Perché ha offuscato tutto il resto. E tutto il resto, in Kerouac, è una disperata tormentata eccentrica ricerca di Dio, una ricerca che trafigge tutti i suoi scritti. Ma il bello è che Kerouac non ha mai un rapporto pacificato con Dio. Ora lo prega, ora dice di essere “un pazzo che ama Dio”, di essere innamorato di lui, ora si ente abbandonato, ora deforma il suo volto, lo accusa, lo bestemmia, arriva a dire che Dio (God) è solo il nome cane (dog) scritto al contrario. E ancora lo chiama “il giudice assente”, lo bolla come “Colui-che-odia”. Kerouac, in questo, è davvero un mistico. È il mistico è colui che dà del tu a Dio, che fa a pugni con Dio, oscillando tra i due poli che sono l’esperienza comune di tutti i mistici: quello della prossimità con Dio, lo sciogliersi in lui, quello della distanza irraggiungibile con Dio, l’assoluta lontananza. Il mistico mette in crisi tutte le categorie del religioso, a partire dal ruolo dell’istituzione. A maggior ragione lo ha fatto Kerouac che è stato anche buddhista e ha mischiato cattolicesimo (peraltro un cattolicesimo con forti venature gnostiche) e buddhismo. Meister Eckhart arriva a pregare Dio perché lo liberi da Dio.
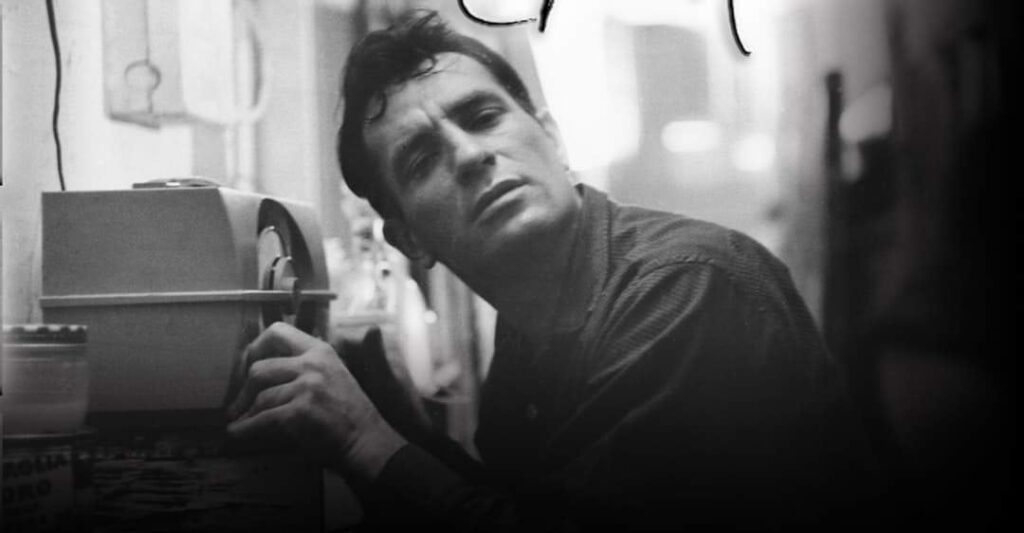
Il movimento beat è stato un grande calderone dentro il quale si agitava di tutto, si trovava di tutto e non sempre con risultati estetici degni. Il mio approccio a Kerouac, ci tengo a dirlo, non è estetico, non misura della sua opera in termini di “riuscita” letteraria, alcune sue pagine sono davvero illeggibili, come quando in Visioni di Cody, per esempio, trascrive intere lunghissime noiose conversazioni. Il mio lavoro su Kerouac nasce dalla passione. Come non si può amare chi scrive che “sacra è vita e ogni suo momento prezioso”? Come non trovare ispirazione nel suo manifesto poetico e di vita: “rotolarsi nel fango per testimoniare la verità cristallina della misericordia”? Oggi amo Kerouac ancora di più perché è stato sconfitto. È stato sconfitto a livello personale e a livello, diciamo così, sociale. Ne I vagabondi del Dharma sognava la rivoluzione degli zaini, migliaia di giovani con lo zaino sulle spalle che avrebbero elargito “visioni di libertà eterna”, i pazzi zen come li chiama, i pazzi di vita, i beat che, ci spiega Kerouac, sono i beati, quelli che vivono un’esperienza di beatitudine. Se pensiamo a come siamo messi oggi, possiamo cogliere la portata tragica del fallimento di Kerouac, del fallimento del sogno di libertà che la poetica beat portava nel mondo. Eppure, nonostante questo, in alcune sue pagine, risuona un amore potentissimo per la vita e per la strada. Per la libertà. È questa la sua più bella eredità.

Il rock deve molto a Jack Kerouac, è in debito Springsteen, è in debito Tom Waits. La domanda che mi ha guidato mentre scrivevo “Il vangelo secondo Bruce Springsteen” e poi “Il vangelo secondo il rock” con l’amico Massimo Granieri, è stata questa: è ancora possibile scavare dentro la narrazione del sacro, dentro la narrazione del religioso, nuove piste di senso? Nuovi spazi di liberà? Nuovi modi di intendere e guardare alla fede? Spesso le parole, diciamo così, ufficiali, ortodosse appaiono stantie, stanche, ossificate. Sono state ripetute per secoli. Allora la musica rock, proprio per la sua vocazione “eretica”, fa risuonare “altre” parole. Io la chiamo questo modo di approcciarsi alla fede inquietudine, altri potrebbero chiamarlo spirito. Lo ha scritto magnificamente Gabriella Caramore: “Pian piano le codificazioni hanno prevalso, fino a rendere i linguaggi del religioso obsoleti, aridi, avulsi dalla vita degli esseri”. In questo senso Jack Kerouac è davvero un autore meraviglioso perché spalanca orizzonti nuovi. Qualcuno ha definito Kerouac l’epitome del paradosso. Kerouac complica tutto, confonde tutto, è sempre spiazzante inatteso. Rileggere la sua opera è stata una sfida difficile e meravigliosa.
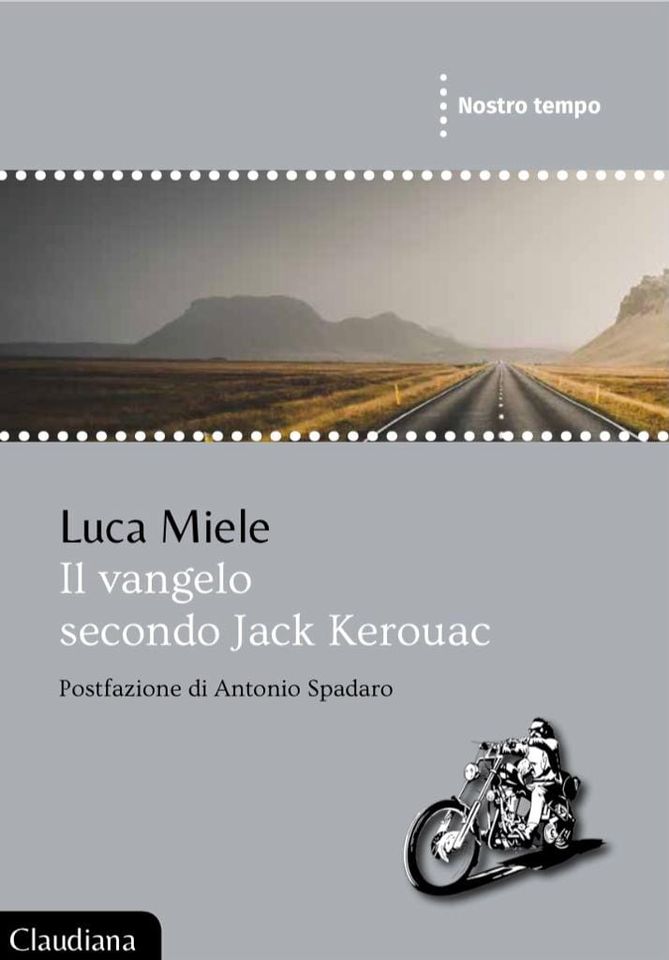
Mi piacerebbe che i lettori di questo libro ne rimanessero confusi. Mi piacerebbe che Kerouac ci confondesse, che ci spingesse a mettere da parte qualche certezza, che ci spingesse a pensare l’impensato, che allentasse alcuni vincoli. C’è una frase di Ignazio Silone che suona più o meno così: l’unico modo per salvarsi è andare allo sbaraglio. Ecco, Kerouac è uno che andato allo sbaraglio, e la sua parabola esistenziale testimonia anche quanti rischi ci siano, quanto sia pericoloso “andare allo sbaraglio”. Come accade, per esempio, con la santità: la santità di Kerouac, la santità dei suoi personaggi è una santità capovolta, una santità che non esclude la carne, le viscere che anzi sprofonda in esse, sprofonda fino all’abiezione. L’immersione totale, estatica, anche orgiastica nella vita, può portare, come accade a molti personaggi di Kerouac, alla dissoluzione, fino alla perdita di sé. Ma l’inquietudine, letteralmente ciò che ci strappa alla quiete, è anche ciò che ci fa sentire liberi. E vivi.

