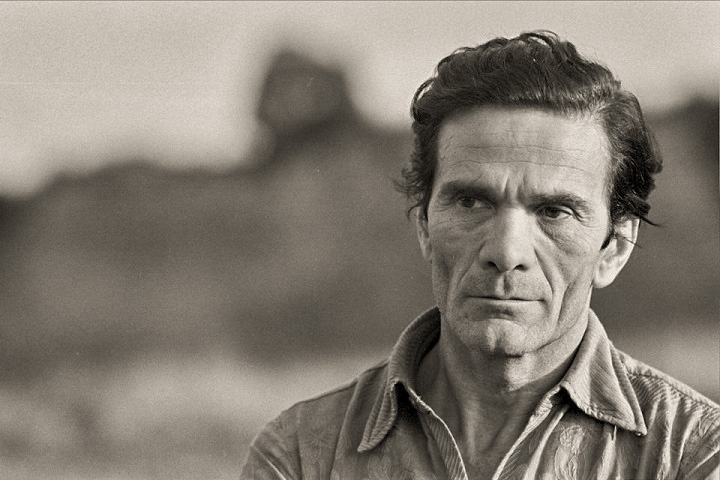Petrolio è un libro incompiuto che Pasolini aveva iniziato con l’idea di restare impegnato tra le sue pagine per anni, forse per il resto della sua vita, perché avrebbe rappresentato una summa di tutte le sue esperienze e di tutte le sue memorie. Sappiamo com’è finita. Il romanzo è rimasto non concluso, quando la vita s’è interrotta. Avrebbe dovuto essere un libro di oltre duemila pagine, il poeta ne aveva scritte appena seicento quando perse la vita per mano criminale, in parte le aveva fatte leggere a Moravia, molte erano ancora da correggere, altre appena abbozzate. E poi non era un romanzo, non avrebbe mai potuto esserlo, pure concluso, caso mai un anti romanzo. Petrolio – o Vas come pretendono altri, una sorta di suggestione dantesca a metà strada tra grazia e sesso – è composto da una serie di appunti numerati, di propositi, di cose da fare, di descrizioni accorate, di ricordi, di spezzoni di trame, di parti di capitoli ripetute. Un Satyricon moderno, diceva Pasolini, un’edizione critica di un testo inedito, materiali, lettere, testimonianze, storia di due personaggi con uno stesso nome con vite diverse, iniziazione erotica e politica, descrizione d’un mondo in perenne divenire. Un libro che sarebbe stato importante, una volta finito, per approfondire l’idea della società consumistica che cambia le persone, per affondare il dito sulla piaga dell’uniformità dei volti e dei linguaggi, per rimpiangere un’Italia contadina dalle differenze nette e decise. Petrolio resta un’opera da leggere e da rileggere per le intense suggestioni che provoca, pur nella sua confusa incompletezza. Ed è così che nel corso degli anni ho letto Petrolio almeno cinque volte, in stagioni diverse, per tentare di capire. La mia ultima lettura, compiuta durante la caldissima estate 2022, quasi per intero sulla spiaggia cittadina di Salivoli ha prodotto questa sorta di racconto, scritto in buona parte con le parole di Pasolini. La Roma periferica del poeta è troppo simile al lido proletario della mia infanzia e ai suoi cadenti quartieri industriali, la storia che segue (che come Petrolio non è una storia, non ha una trama) va letta come se Salivoli fosse Ostia e il Cotone una cadente Pietralata in abbandono.
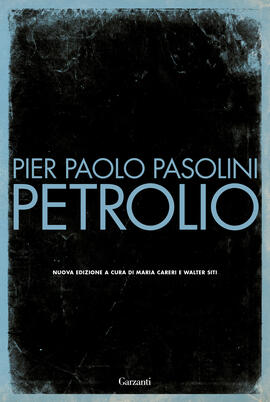
Una casa affittata ai Parioli, immalinconita dall’atmosfera che hanno i luoghi in declino con vecchi giardini che hanno avuto troppi padroni, un’architettura vecchia. Un passaggio di nuvole antiche, quasi mitiche, poi torna il sereno, il sole splende, nulla si frappone tra la città e la luce. Il cielo è di un azzurro perfetto, tutto luce, fecondato da luce, un azzurro velato, marino, che pare venire dal passato. Siamo nel cuore dell’estate, nel cuore del silenzio, pieno e assoluto, che fa da canale del ricordo. Un bagno di luce sul lungomare e su campagne deserte. Le case nuove sono piccole palazzine di dadi bianchi. Un caos di muraglioni scrostati e di catapecchie, fabbriche in disuso e stabilimenti abbandonati. In fondo brilla il mare e una città sconfinata alle spalle. Odore di terra concimata e salmastro, di limoni e zolfo, di soffocante tempo perduto. Polvere della povertà, in fondo. Un lungo crepuscolo ammassa oro e rosso sangue, come in un vecchio film di Joe D’Amato. Finisce tutto in un rosso bronzo e nella visione di palazzi moderni e grigi, caserme o prigioni, che seppelliscono la vitalità d’una terra perduta. La notte inghiotte tutto in una voragine di buio, assoluta come il petrolio, nera come la pece. Per fortuna una salvifica luna (lattiginosa e greve) – come quella che appare a Salivoli, intensa e piena, color rosso stemperato, sulla mia spiaggia notturna, non così dissimile da Ostia e dal suo mare – diffonde una luce lieve. L’odore del mare si mescola con la luce della luna che ritaglia un angolo di mare; il grigiore dell’alba fa comparire la città anticipando il dilagare del sole. Le case della mia infanzia, senza televisione, frigorifero, né spreco di beni di consumo; ci si scalda con la stufa, in camera da letto basta una coperta imbottita o uno scaldino. Identici cibi. Identici odori. Identiche stagioni. Odori per strada andando a scuola, lungo i selciati. Odore di terra e di bruciato, profumo di glicini a primavera. Acuto odore di pietra senza odori o di terra gelata in inverno. Una scuola nuda, povera, vecchia, proprio come il palazzo liberty della mia piazza Dante. Persone tutte uguali, nei loro ruoli immodificabili. È il tardo meriggio della mia adolescenza, una luce matura, dolce, di catastrofe, illumina di taglio le cose, mentre odo il rullare monotono e affascinante delle ruote del treno sulle giunture dei binari. Una periferia vecchia maniera che va diradandosi verso il mare e la piena campagna illuminata dalla luce, splendente del sole; distese di grano e girasoli, praterie selvagge, tigli in fiore e cespugli di gaggie; panorama inaridito da un’estate tropicale che scopre d’un tratto ciminiere di mare. Disperata solitudine. Una sera violetta. Le rondini volano alte, la gente rincasa, voltando le spalle alla luce che persiste come un fossile ardente imbiancando il cielo olivastro. Una notte boreale che ancora biancheggia di luce. Restano le stelle, le stupende stelle della giovinezza. È una mattina ardente di giugno, l’estate è arrivata di colpo, l’asfalto e le pietre scottano, e all’afrore delle immondizie bruciate da un sole che più limpido e puro è impossibile immaginare, si mescola l’odore delle piante selvatiche che prorompono dappertutto: tra i tuguri delle bidonvilles, tra i vecchi caseggiati, tra le fabbriche, sugli argini del fiume che porta dentro la città il verde selvaggio e sporco della campagna vicina. In quel sole immemorabile d’una limpidezza eccessiva, torbida e lattiginosa, si svolge la vita pigra e silenziosa del vecchio borgo. Tutto intorno un’assordante baraonda di auto, camion, furgoni, biciclette, motorini e una folla immensa, ansiosa, vociante … Il sole entra dentro le cose con un fosco, secco splendore. La luce trasuda da membra povere e brune, da visi ossuti, da occhi che mandano lampi d’una nerezza famelica, da nuche tosate, da voci rauche per il gran gridare e il motteggiare, cominciato all’alba quando fuori è ancora buio. Rimpianto degli anni Sessanta, quando riconoscevi un proletario dai tratti del volto, dal modo di camminare. E vedevi un borghese, un intellettuale, solo dal modo in cui parlava. Tempi netti e decisi, pretelevisivi, pre-internet, con differenze marcate. Salivoli e la sua spiaggia notturna, com’era alla fine degli anni Cinquanta, rimasta uguale, in fondo, arenile immodificabile.
La luce del pomeriggio è dolorosa, tutto fa male, tutto prende alla gola, la vita si presenta come un paese di confino, dove dei pazzi credono d’essere liberi e vivono la loro giornata come un diritto. La dolce sera, invece, vede le atroci nuvolette cominciare a farsi rosa, il verde dei prati diventa bruno e si stempera nella grande ovatta del tramonto. E la gente sembra rianimarsi, rifuggendo alle fitte di dolore dei prati cosparsi di gialle e anonime margherite, distese di grano e orzo, segale e frumento, sotto un sole abbagliante. Resta l’ebbrezza della solitudine, il mistero delle vite dei padri, eterna ripetizione d’un modello che rende uguali tutti i contenuti, che emana dalle folte erbe dei giardini, le piante mezzo selvatiche come le acacie che possono traboccare tra le immondizie, lungo certi muri scrostati o certi steccati fradici. La pioggia caduta durante il giorno si è annidata dietro quella povera vegetazione e l’improvviso tepore la fa profumare. Solo apparentemente il mare è immobile. In realtà sulla spiaggia, tra l’immondizia nerastra, esso si muove come sempre, rotolando con ostinazione incessante, ondata dopo ondata, cascanti inerti ondate, il cui orlo di spuma, di un’eleganza stupenda, è un’apparizione ogni volta troppo breve, su quella sporcizia umana e su quella tristezza del mondo. Il mare finisce con l’alzare sopra il frangente una specie di colonna bianca di lieve umidità, che resta sospesa come l’ombra d’un fantasma nella foschia che copre tutta la pioggia quant’è lunga. Forse non è più notte e comincia ad albeggiare; e da ciò quell’innaturale biancore. Adesso mi resta solo la voglia di dormire in un letto ebbro di antichi odori contadini.